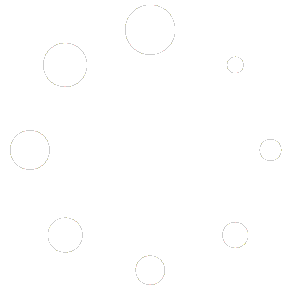La pienezza del vuoto
“Cambia lo superficial,
cambia también lo profundo,
cambia el modo de pensar,
cambia todo en este mundo…
Cambia todo cambia…”
testo di Numhauser – Interpretata da Mercedes Soza
Che cos'è il vuoto
Siamo spesso propensi a pensare che vuoto equivalga a nulla. Niente. Zero. E nessuno vuole stare nel nulla perché fa paura, soprattutto oggi che sentimenti quali ansia, angoscia, senso di inadeguatezza e non appartenenza sono stati d’animo molto presenti nell’essere umano. In realtà, il vuoto a cui ci riferiamo, è necessario per fare spazio a qualcosa di più grande, di più profondo, che sta dentro ognuno di noi.
Fare spazio
Può accadere di svegliarsi un giorno e non riconoscersi più. Ci si accorge di aver vissuto fino a quel momento la vita di qualcun’altro, di aver respirato con il ritmo di qualcun altro, di aver corso quando avremmo voluto andare più piano. Siamo stati scambiati per forti, ma in realtà eravamo fragili, avremmo voluto una carezza in più, ci si trova con il cuore arido e spezzato. Ecco allora che arriva il momento di fare spazio, come quando si riordinano le cartelle del computer e si libera l’hard disk. È proprio questo il processo: si inizia ad uscire da quello stato di non conoscenza, che in sanscrito viene definito avidya, il non vedere le cose per come sono realmente. In ambito buddhista così come in quello yogico, questo spazio viene indicato con il termine shunya che, letteralmente, significa “vuoto”. È un vuoto da tutti i condizionamenti, da tutte le identificazioni, da tutto ciò che ci siamo costruiti da quando abbiamo cominciato a dire i primi “no”, facendo prevalere il nostro piccolo io e cominciando a costruire la nostra personalità. E’ una sorta di stato di grazia, così stupefacente che, nei piccoli e brevi istanti in cui si sperimenta, non esistono parole per descriverlo. Si può solo viverlo.
Cosa ci dice Patanjali
Negli Yogauūtra, Patanjali parla di sukha che letteralmente significa “esperire agio”, e duhkha che significa invece “esperire disagio”. Dunque vi è una coppia di opposti, tra attrazione e avversione, che porta l’essere umano a desiderare di ripetere e ricercare all’infinito ciò che gli piace e lo rende felice (rāga, che letteralmente significa “attrazione”) e a volersi invece allontanare da ciò che non gli piace e lo fa soffrire (dvesha, che letteralmente significa “avversione”), creando così un senso di costante attaccamento alla vita. Sarà allora un profondo lavoro su de stessiche darà inizio all’esperienza del vedere per andare incontro al vuoto che è sempre lì, pronto ad aspettarci.
Fare esperienza di shunya
Nella nostra quotidianità possiamo fare esperienza di shunya attraverso la pratica degli asana che, rendendoci attenti e sempre più presenti al nostro corpo, hanno la capacità di acquietare il costante flusso di pensieri, e attraverso la pratica del pranayama, tecniche di respirazione yogica e di meditazione che portano l’uomo in direzione dell’autentico ascolto di sé. Rimanere seduti, vigili, in osservazione del proprio respiro, delle pause tra la fine dell’espiro e l’inizio dell’inspiro e viceversa, delle proprie sensazioni, emozioni, di tutto ciò che accade nel momento presente ci può aiutare, anche se per pochi istanti e in modo discontinuo, a prendere le distanze dai nostri conflitti, invitandoci a diventare così abili osservatori del lila, il “gioco” a cui stiamo partecipando. Lila è il gioco di Dio.
La pienezza del vuoto
Essendo normalmente abitati dalle coppie di opposti, uno degli aspetti più difficili della pratica è la capacità di prestare attenzione alle proprie distrazioni, a tutto ciò che ci ossessiona, ci insegue e che sale all’emergenza proprio nel momento in cui ci si siede, immobili e in silenzio, senza porre giudizio. Senza giudicare ciò che accade, senza nulla aggiungere, trattenere o respingere. Senza attaccamento e senza avversione. Ma cosa ci facciamo lì seduti, immobili, ad occhi chiusi, con la schiena dritta, simulando un corpo senza vita? Nulla, niente e nello stesso tempo… tutto. E’ così che la pienezza si fa avanti. Passo dopo passo prende piede. Occupa il posto di tutto quello che prima ci ingombrava. Mentre siamo seduti, inattivi, si inizia a comprendere che il mondo non dipende da noi, che tutto cambia, tutto è transitorio, tutto è vacuità, nulla è stabile.
Tutto cambia…
Nulla permane: il giorno che lentamente si fa notte, le stagioni che entrano una nell’altra senza far troppo rumore, il nostro aspetto fisico che cambia quotidianamente, gli esseri che ogni istante nascono, crescono, si trasformano e muoiono lasciando il posto a nuovi organismi viventi. Se si fa la prova soffermandosi su di un pensiero, ci si accorgerà ben presto che anche lui, silenziosamente, svanirà. Si dilegua fino ad arrivare a un senso di unità, di osmosi tra voi e il mondo e l’universo. Fino a che non c’è più differenza. Occorre provare a fermarsi tra la fine di un pensiero e l’inizio del successivo come in uno spazio interstellare, infinito. Noi non siamo i nostri pensieri, senza per questo perdere identità. L’essere umano E’, quando i pensieri non ci sono. Questa è la pienezza del vuoto: quando ci svuotiamo di quello che non siamo. E possiamo accorgercene solo ascoltando, come quando eravamo piccoli e abbiamo imparato ad ascoltare prima di poter iniziare a dire le prime parole. Eravamo solo ascolto, paziente e generoso.
Senza paura
Non dobbiamo avere paura di avvertire che i nostri pensieri, con il passare del tempo, diventano meno virulenti. L’essere umano continuerà sempre a pensare, la mente è fatta per questo, ma è l’attaccamento al contenuto dei nostri pensieri si affievolirà col tempo. I pensieri sono come gli uccelli più svariati che nidificano sui grandi alberi, volano via e poi ritornano, poi volano ancora via lontano, ma la natura degli alberi rimane sempre la stessa, non cambia mai.
Articolo scritto da Laura Dajelli, fondatrice e direttrice Rhamni, insieme a Francesca Viola Molinari, formatrice e insegnante di yoga